SENTENZA CIVILE – Nullità e inesistenza della Sentenza– Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 642 del 16/01/2015 : Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sancito che “La mancanza formale della concisa esposizione dello svolgimento del processo, come anche l’indicazione delle parti e delle conclusioni, non integra un motivo di nullità della sentenza se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti e considerati o presupposti nella decisione.”
Testo Integrale: Cassazione Civile, Sezioni Unite N. 642/2015 del 16/01/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente f.f. Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Sezione – Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione – Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere – Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere – Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere – Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere – Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24161/2010 proposto da:
FALLIMENTO S S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato P B, rappresentato e difeso dall’avvocato C G, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, , presso l’Avv, che la rappresenta e difende e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 475/40/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 02/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. C D I;
uditi gli avvocati G C, A V dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. C P P M, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
L. s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone l’avviso col quale, ritenuta l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2000 ed accertato pertanto induttivamente il reddito per l’anno in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato Euro 665.612,08 per Irpeg, Euro 249.817,43 per Irap ed Euro 2.846.653,78 per Iva, oltre interessi e sanzioni per Euro 4.505.653,68. Il giudice adito rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 475/40/09 pubblicata il 2.10.2009, rigettava l’impugnazione proposta dalla società, confermando la sentenza di primo grado.
In particolare nella citata sentenza i giudici d’appello, premesso di fare proprie le argomentazioni esposte dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, hanno rilevato che l’accertamento nei confronti della società era stato effettuato perchè, alla stregua del disposto del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, era stata considerata omessa la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta in contestazione in quanto redatta su modello non conforme a quello previsto dalla legge, non inviata telematicamente e priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società.
I predetti giudici hanno inoltre evidenziato la pretestuosità del rilievo della società – secondo la quale al momento della presentazione i nuovi modelli non erano disponibili -, sottolineando il carattere non esclusivamente formale della prescrizione di utilizzare un modello specificamente predisposto e di procedere all’invio telematico, ed hanno altresì rilevato: che, considerata la chiarezza della norma, non si ravvisavano i presupposti dell’errore scusabile; che, essendo stata omessa la dichiarazione e non essendo stata fornita risposta ai questionari inviati nè essendo state fornite agli uffici finanziari le notizie richieste nell’ambito dei loro poteri istruttori, l’Ufficio era legittimato a determinare il reddito complessivo sulla base delle notizie e dei dati dei quali aveva comunque avuto conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalla dichiarazione e dalle scritture contabili in quanto esistenti ed avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che non sussisteva alcuna preclusione all’accertamento dell’anno 2000 per intervenuto condono in quanto il condono non si era perfezionato. Infine, i giudici d’appello hanno precisato che il reddito complessivo era stato determinato ricostruendo i ricavi della gestione ordinaria sulla base dei costi diretti di produzione rilevati dal bilancio di esercizio e dalla copia della dichiarazione consegnata all’Ufficio, evidenziando che i ricavi della gestione ordinaria inseriti in bilancio non erano assolutamente rispondenti alla situazione reale dell’azienda, non risultando peraltro convincente la motivazione fornita nella relazione dell’amministrazione sulla gestione – attribuente la riduzione del valore della produzione rispetto all’anno precedente al solo aumento del costo del personale – in quanto essa, seppur condivisibile, non spiegava il comportamento della società, consistente nell’incremento della produzione e nell’assunzione di nuovo personale in un momento in cui, come dedotto nella relazione, si riscontrava aumento dei costi delle materie prime e diminuzione dei prezzi delle lavorazioni.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Fallimento della società.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Il ricorso per cassazione della curatela fallimentare è affidato a ventuno motivi, col primo dei quali, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, si afferma che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio d’appello, senza alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alle tesi dell’Agenzia delle Entrate.
Il collegio della quinta sezione civile di questa Corte, dinanzi al quale la causa è stata chiamata, considerato che la decisione del suesposto motivo (il cui esame risulta necessariamente pregiudiziale) comporta la considerazione di principi di rilevanza anche costituzionale, “con possibili ricadute per eadem ratio pure al di fuori del processo tributario, nei processi civili e penali (nonché nei giudizi disciplinari su comportamenti similari)”, con ordinanza interlocutoria n. 1531 del 2014 ha invocato – ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, – l’intervento di queste sezioni unite sulla questione relativa alla censurabilità (o meno) della sentenza la cui motivazione sia costituita esclusivamente dalla mera riproduzione di un atto di parte.
La censura proposta col motivo sopra riportato è infondata.
Il termine “sentenza” – nella sua accezione di scritto esponente le ragioni di una decisione giurisdizionale – sconta (molto più di altri termini giuridici) gli effetti di non univoche suggestioni culturali che sono andate via via crescendo proporzionalmente all’incremento delle funzioni e delle valenze anche extraprocessuali assunte negli ultimi decenni dalla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, finendo per costituire (anche nell’immaginario collettivo) non soltanto l’esposizione delle ragioni di una decisione, ma pure (spesso innanzitutto) la “prova” e la “misura” (in positivo e in negativo) della quantità e qualità del lavoro del giudice. Sempre più frequentemente infatti la sentenza, con i suoi contenuti, tempi e modalità di intervento, sembra costituire (anche) la risposta a domande eterogenee che sono fuori del singolo processo, divenendo ambiguo e simbolico terreno di confronto intorno al quale soprattutto si misura l’aspettativa di giustizia nonché il modello di giudice (e di processo) che volta a volta si intende promuovere o stigmatizzare.
Sentenza (intesa come motivazione della decisione) è dunque uno di quei termini il cui utilizzo richiederebbe, in funzione della maggiore precisione del discorso, un preventivo “inventario di senso”, o, meglio, una preventiva operazione di “disambiguazione” culturale.
In questa sede tuttavia, pur avvertendosi – nell’impostazione della questione e nelle argomentazioni addotte in ricorso – il peso della denunciata ambiguità culturale di fondo, una indagine siffatta non può che essere solo indirettamente lambita dall’analisi dei temi proposti dal ricorso, da condursi prescindendo dalla dimensione “suggestiva” della problematica in esame, al fine di fare chiarezza su di essa esclusivamente alla stregua della disciplina giuridica vigente, sul piano sostanziale e processuale.
2.- Con riguardo alla disciplina civilistica del diritto d’autore, è sufficiente rilevare che la sentenza non è un’opera dell’ingegno di carattere creativo appartenente “alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia” e pertanto, a norma dell’art. 2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d’autore nelle due espressioni (morale e patrimoniale) considerate dal legislatore. E ciò perchè, al di là di quanto effettivamente creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza, essa non viene in considerazione per l’ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato, come d’altro canto accade per gli atti amministrativi e legislativi nonchè per gli atti dei rispettivi procedimenti prodromici.
Ne consegue che, con riguardo alla disciplina civilistica: la sentenza può essere citata, riportata, ripresa e richiamata in altri scritti senza che si ponga alcun problema di diritto d’autore (nè sotto il profilo patrimoniale nè) sotto il profilo morale, ossia con riferimento alla rivendicazione della paternità dell’opera; nella sentenza non assume rilievo l’eventuale “originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive; nella sentenza può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo (perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che, sotto entrambi gli aspetti (cioè sia con riguardo alla sentenza che all’atto nella stessa riportato), si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche.
Le considerazioni che precedono non esauriscono la problematica in esame, posto che la possibilità – sul piano civilistico – di riportare atti del processo all’interno della sentenza senza che venga in rilievo una questione di paternità degli atti suddetti non esclude che la disciplina processuale possa – esplicitamente o implicitamente – imporre al giudice l’originalità nei contenuti e/o nelle modalità espressive della sentenza, oppure vietargli di riportare (o eventualmente riprendere o richiamare) nella motivazione della sentenza i contenuti di atti processuali (o di altre sentenze).
Occorre pertanto procedere ad un’attenta ricognizione del codice di rito intesa alla individuazione di simili imposizioni o divieti (ove esistenti) ed eventualmente delle sanzioni processuali applicabili in ipotesi di inottemperanza.
Nel codice processuale civile del 1865 non risultano imposizioni o divieti di tal fatta, ma all’art. 361 c.p.c., si afferma che “i motivi si reputano omessi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un’altra sentenza”.
La disposizione non sembra riferibile all’ipotesi in esame. Infatti, considerato, per un verso, che le sentenze intorno alla metà del diciannovesimo secolo venivano scritte dal giudice e ricopiate dal cancelliere (non col computer nè a macchina o con la biro, bensì) con la penna d’oca e il calamaio, e che quindi poteva essere frequente che le motivazioni di una sentenza venissero semplicemente richiamate (non ricopiate) in altra sentenza, e considerato, per altro verso, che nella norma in esame si discute di una sentenza che si sia “riferita” ai motivi (cioè alla motivazione) di un’altra sentenza (non che li abbia ricopiati), è verosimile che con la norma in esame si intendesse stigmatizzare (non la motivazione consistente nella mera ricopiatura della motivazione di un’altra sentenza bensì) la motivazione per relationem in senso stretto (ossia la motivazione contenente solo un riferimento alla motivazione di un’altra sentenza senza però riportarne il contenuto), e ciò non per ragioni di “paternità” dello scritto (o necessaria riferibilità all’estensore della sentenza anche delle modalità espositive utilizzate per rendere ragione della decisione assunta) quanto piuttosto per l’avvertita esigenza di non imporre alle parti di ricercare fuori della sentenza (in un altro atto giudiziario del quale, per le considerazioni esposte, doveva verosimilmente essere assai laborioso ottenere copia) le ragioni della decisione che li riguardava. D’altro canto, se la norma fosse stata invece intesa ad evidenziare la necessità della “paternità” del giudice con riguardo a tutte le articolazioni della motivazione della sentenza – anche nelle relative – modalità espressive -, probabilmente avrebbe fatto riferimento a qualsivoglia altro scritto (ivi compresi quelli di parte) e non solo ai motivi di un’altra sentenza.
In ogni caso la norma suddetta (quali che siano il significato e le finalità ad essa attribuibili) non è stata riproposta nel codice processuale civile del 1940 – attualmente vigente – e neppure in alcuna delle molteplici riforme che lo hanno interessato.
Nel vigente codice di rito non è dato rinvenire neppure alcun’altra norma che, con riguardo alla redazione della sentenza, esplicitamente o implicitamente imponga al giudice l’originalità nei contenuti o nelle modalità espositive. Alla stregua delle disposizioni del suddetto codice deve anzi escludersi che sia contemplata o perseguita una qualche forma di “originalità” con riguardo ai contenuti della decisione, considerato che, giusta le disposizioni predette, il giudice deve decidere su tutta e non oltre la domanda (da qualificarsi non solo in rapporto al petitum ma anche alla causa pretendi); deve decidere iuxta alligata ac probata senza porre a base della decisione fatti e prove non ritualmente introdotti dalle parti nel processo, essendogli vietato fare riferimento alla propria scienza privata; deve decidere (salvo i casi di pronuncia secondo equità) in base alla legge, tenendo in considerazione (alla luce del principio di nomofilachia introdotto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e riaffermato dalle recenti riforme del codice di rito) l’interpretazione della legge fornita dal giudice di legittimità, salvo che non ravvisi valide ragioni per discostarsene; deve infine evitare le c.d. “sentenze della terza via”, in particolare evitando di porre a fondamento della decisione questioni rilevate d’ufficio che non siano state previamente indicate alle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 384 c.p.c., comma 3.
Neppure l’originalità nelle modalità espositive della sentenza risulta – esplicitamente o implicitamente – richiesta, contemplata o anche solo “auspicata” nel codice di rito. Nel suddetto codice si richiede infatti che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e – prima della riforma del 2012 – si richiedeva altresì che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta mai richiesta una motivazione espressa con modalità espositive “inedite”.
Infine, nella disciplina processuale civile non risulta in alcun modo vietato riportare in sentenza il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o più in generale atti processuali) la cui paternità non sia attribuibile all’estensore. Anzi, specie nelle riforme legislative degli ultimi anni (varate o ancora allo stato di proposta) e nella giurisprudenza di legittimità, sembra emergere una tendenza addirittura contraria.
E’ noto che la giurisprudenza italiana dell’ottocento e dei primi decenni del novecento si segnalò soprattutto per le sue sentenze solenni, paludate, compiaciute e barocche, vere e proprie occasioni per fare sfoggio della cultura e dello “stile” del giudice. Si trattava della espressione di una civiltà ancora in gran parte rurale e di una società condizionata da un diffuso analfabetismo, in cui scrivere, leggere ed esprimersi in maniera corretta non poteva ritenersi affatto scontato ed il “bello scrivere” era anzi un valore da esibire, essendo pertanto culturalmente inconcepibile (anche se non espressamente vietato) che un giudice utilizzasse nei propri scritti il frutto della “fatica” espositiva altrui.
Le sentenze dell’epoca, redatte in maniera ampollosa e spesso caratterizzate da sovrabbondanza di lessico, enfasi declamatoria, eccesso di astrattezza, erano comprensibili solo ad una ristretta cerchia di persone e segnavano dunque in maniera palese la distanza linguistica tra chi era nel “palazzo” e chi stava nella piazza, distanza abissale che peraltro riguardava lo stile di tutti gli atti ufficiali dell’epoca (comprese le leggi e gli atti amministrativi).
Col codice di rito comincia a farsi strada una diversa concezione culturale della sentenza, se si pensa che già il legislatore del 1940 pone l’accento sulla necessità di una motivazione “concisa” e non eccedente la propria funzione, identificata essenzialmente nella esposizione delle ragioni della decisione assunta e non nella manifestazione delle capacità argomentative ed espressive del giudice, non dovendo la sentenza essere un “trattato” (come indirettamente evincibile anche dal divieto di citare autori giuridici). E questa concezione viene vieppiù supportata dalla funzione anche extraprocessuale che la Costituzione attribuisce all’obbligo generalizzato di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Le successive riforme del codice di rito in materia sembrano andare tutte nella medesima direzione. In particolare, con la riforma del 2003, relativa all’ormai abrogato rito societario, il legislatore fa un ulteriore passo avanti sulla strada della semplificazione e “funzionalizzazione” della sentenza, per la prima volta prevedendo che “la sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi”. Proseguendo questo percorso (ormai reso inevitabile anche dalla necessità di dare concreta attuazione al principio costituzionale di ragionevole durata del processo), con la L. n. 49 del 2009, il legislatore estende a tutte le sentenze (non più solo alle ordinanze) la previsione di una motivazione (non solo concisa ma addirittura) succinta, prevede anche fuori del rito societario la possibilità di una motivazione che possa essere esposta pure mediante il “riferimento a precedenti conformi”, elimina la necessità di esporre in sentenza lo “svolgimento del processo”, sostituisce ai “motivi in fatto e in diritto della decisione” le “ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Che le riforme in esame non rappresentino interventi episodici ma l’espressione di un diffuso sentire nel modo di concepire la sentenza è testimoniato dal fatto che il trend in esame trova riscontro, in maniera perfino più incisiva, anche nella disciplina processuale dettata per le giurisdizioni speciali, basti pensare, ad esempio, all’art. 129 della legge sul processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) che, nell’ambito del contenzioso elettorale, al sesto comma prevede la possibilità che la motivazione della sentenza possa “consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”.
La profonda evoluzione che soprattutto negli ultimi decenni ha interessato la sentenza e la sua motivazione non è stata tuttavia determinata soltanto dai ripetuti interventi del legislatore in materia, ma anche, spesso ancor prima, dalla giurisprudenza di legittimità, che, prendendo atto dei molteplici cambiamenti intervenuti nella società (ad esempio con riguardo al mutamento degli strumenti utilizzati per la scrittura e la copia degli atti, all’aumento vertiginoso del contenzioso, alla necessità di definire le controversie in tempi ragionevoli) ha in modo significativo contribuito a modificare la “cultura” della sentenza civile.
E se è vero che, con particolare riguardo alla specifica problematica in esame, in alcune (non recentissime) pronunce questa Corte ha ritenuto non sufficiente la motivazione della sentenza che si limiti a trascrivere e condividere la difesa di una delle parti senza esplicitare le ragioni di tale condivisione (v. Cass. n. 10033 del 2007) ed ha affermato la nullità della sentenza del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, non potendo considerarsi “motivazione” la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti – peraltro neppure enunciata nel provvedimento – (v. Cass. n. 12542 del 2001), è anche vero che dalla lettura complessiva delle decisioni di legittimità in materia di motivazione emerge un approccio della Corte di cassazione alla motivazione della sentenza che non è più “curiale” ma piuttosto laico, funzionalista, in certa misura “disincantato”.
Ad esempio, ammettendo la possibilità di motivare per relationem, questa Corte ha affermato che la completezza e logicità della sentenza motivata in tal modo deve essere giudicata sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio, atto che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante. Inoltre, richiamando la normativa in tema di motivazione per relationem degli atti amministrativi, ha precisato che il rinvio deve essere fatto ad atti ben individuati e conosciuti o conoscibili (v. Cass. n. 13937 del 2002 e anche SU n. 16277 del 2010 che ha fatto applicazione del principio in materia disciplinare, con riguardo a sentenza rinviante ad atti del procedimento penale cui era stato sottoposto il magistrato, acquisiti al procedimento disciplinare), ritenendo pertanto, anche dopo l’abrogazione della sopra citata previsione del rito societario, ormai ammissibile una sentenza che rinvii ad atti presenti nel fascicolo processuale – da ritenersi perciò parte integrante della motivazione senza necessità che siano trascritti -.
Inoltre, già prima della riforma del 2009 – che ha eliminato la necessità di esporre in sentenza lo svolgimento del processo – questa Corte aveva precisato che la mancanza formale della concisa esposizione dello svolgimento del processo – come anche della indicazione delle parti o delle conclusioni (che la riforma del 2009 non ha soppresso) – non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione (v. tra le altre Cass. n. 3066 del 2002).
Nè può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime altre Cass. n. 22801 del 2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272 del 2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007).
Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell’ottica della semplificazione e dello “snellimento” del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. Cass. nn. 1570 del 1984; 275 del 1995 e – più recentemente, benché la diffusione del p.c. abbia diminuito di molto, anche nelle cause seriali, l’uso di prestampati – 24508 del 2006).
La giurisprudenza di legittimità aveva inoltre – anche anteriormente alle riforme che ne hanno potenziato la funzione nomofilattica – sostenuto che soddisfa l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., il mero riferimento da parte del giudice del merito alla giurisprudenza di legittimità in relazione alla soluzione di una questione univocamente espressa dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 3275 del 1983) e che soddisfa tale obbligo anche la sentenza che, nell’interpretare una norma di legge, faccia integrale riferimento alla lettura data alla predetta disposizione da parte della Corte di cassazione (v. Cass. n. 2282 del 2004), chiarendo ulteriormente che è immune da vizi la motivazione della sentenza di merito con la quale il giudice si limiti a riportare l’orientamento, sulla questione discussa e decisa, della giurisprudenza di legittimità, aggiungendo di condividerlo e di volervisi uniformare, atteso che anche in tal caso ed in tal modo risultano esposte, sia pure concisamente, le ragioni giuridiche della decisione (v. Cass. n. 3905 del 1999).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ormai da decenni afferma che il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (v. tra le altre Cass. nn. 2114 del 1995; 26694 del 2006; 10222 del 2009 e 28647 del 2013).
Alla luce dell’excursus che precede (necessariamente non completo, ma utile a tratteggiare sia pure in grandissime linee il contesto giurisprudenziale nel quale deve essere valutata la problematica in esame) deve riconoscersi una tendenziale coerenza del giudice di legittimità nell’interpretare il contenuto dell’obbligo costituzionale di motivazione al di là di ogni formalismo, riconducendo sul piano esegetico ad unità le diverse previsioni processuali riguardanti la materia attraverso una lettura delle medesime ispirata a principi di effettività e funzionalità.
La sentenza che emerge dagli interventi censori della giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni è infatti una sentenza funzionale, flessibile, deformalizzata, improntata al contemperamento delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso la conciliazione, in apparenza difficile, tra una motivazione comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia tuttavia concisa, succinta ed in ogni caso tale da giungere in tempi (più) ragionevoli.
E, d’altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’inammissibilità dei ricorsi contenenti la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali mediante la tecnica dell’assemblaggio non certo per mancanza di originalità contenutistica o espositiva del ricorso bensì per inidoneità del medesimo a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto tali ricorsi, siccome carenti di sintesi funzionale, finiscono per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevi in ordine ai motivi di impugnazione (v. SU n. 5698 del 2012 e successive conformi).
3.- Sulla base della disciplina sostanziale e processuale vigente, nonché avuto riguardo alle grandi linee di pensiero lungo le quali negli ultimi decenni si è mossa, con sostanziale univocità, la giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione, deve pertanto concludersi che per il diritto positivo non si pone un problema di “originalità” ovvero di “paternità” con riguardo alle modalità espressive utilizzate in motivazione, tanto meno con riguardo ai contenuti di essa, e ciò non certo perché, secondo il legislatore e la giurisprudenza, possa ritenersi consentito al giudice attribuirsi la paternità di uno scritto altrui o perché la sentenza possa essere “copiata” da un altro scritto, giacché, in tali termini, la questione in esame non risulta correttamente individuata ed impostata.
Come innanzi rilevato, infatti, la sentenza è un atto pubblico, espressione di una funzione pubblica, non un’opera letteraria. I relativi parametri di valutazione sono pertanto “altri” rispetto all’originalità della forma espressiva (perché di questo alla fine si tratta, considerato che una “originalità” della decisione e delle ragioni che la sostengono, come valore in sè, non è neanche concepibile o auspicabile); altri sono i criteri sulla base dei quali la decisione e la relativa motivazione devono essere apprezzati.
In particolare, quel che conta innanzitutto non è che la suddetta decisione e le relative motivazioni siano o meno “inedite” nè che le modalità espressive utilizzate siano o meno tratte da altri scritti, ma che la decisione e l’individuazione delle ragioni che la sostengono siano attribuibili al giudice, costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato che attraverso il giudice si esprime, ed inoltre che esse siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerente ed esaustiva, perché la sentenza, una volta emessa, esprime, come già rilevato, la volontà dello Stato rendendone manifesto il comando, e va pertanto valutata oggettivamente, per quel che da essa risulta, a prescindere dai percorsi psicologici o dalle performances espositive dell’estensore, riguardo ad essa potendo anzi porsi un’esigenza di “desoggettivazione”, in relazione al rischio di una sua esuberanza rispetto alla corrispondente funzione, potenzialmente idonea a renderla strumento di protagonismo.
Il “proprium” dell’attività del giudice, della sua funzione e professionalità sta dunque nella decisione e nella individuazione delle ragioni che la sostengono, le quali, ripetesi, devono essere corrette ed esposte chiaramente, non a tutti i costi “originali” e/o esposte in maniera “originale”, essendo l’attribuibilità al giudice (con tutte le relative conseguenze anche in termini di responsabilità) della decisione e della individuazione delle ragioni che la sostengono cosa diversa dalla “paternità” delle relative modalità espressive, neppure richiesta dal codice nè tutelata dal diritto d’autore.
Deve peraltro considerarsi che la sentenza è l’atto conclusivo di un processo nel quale hanno agito più soggetti, ciascuno in certa misura contribuendo alla decisione finale, la quale, sotto questo profilo, può essere considerata un risultato “corale”. Il compito del giudice (gravoso, spesso assai complesso, in ogni caso mai “facile”) è proprio quello di valutare, tra i fatti dedotti e i diritti vantati, le ragioni sostenute e le pretese avanzate, le prove addotte e le argomentazioni spiegate, quel che di volta in volta sia da ritenersi giuridicamente corretto e “verificato” in fatto, quindi quanto risulti effettivamente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Una volta assunta la decisione ed individuate le ragioni, giuridiche e di fatto, che la sostengono, deve pertanto riconoscersi al giudice la possibilità di esporle nel modo che egli reputi più idoneo – purchè in lingua italiana, succintamente ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva -, perciò anche (se lo ritiene) attraverso le “voci” dei soggetti che hanno partecipato al processo (parti, periti). E può farlo sia richiamando i relativi atti sia direttamente riportandoli (in tutto o in parte) nella sentenza, e, in quest’ultimo caso, può utilizzare indifferentemente le virgolette o la tecnica del discorso indiretto, perché, trattandosi di atti anch’essi non costituenti opere letterarie e non protetti dalla disciplina del diritto d’autore, non rileva che ne sia riportato esattamente il testo virgolettato con indicazione della fonte, e, al contempo, non importa che possano sorgere equivoci in ordine alla “paternità” di quanto riportato, e ciò non solo perché dalla logica del testo potrebbe essere comunque comprensibile la fonte (come nel caso di specie, in cui l’estensore, prima di riportare in sentenza – sia pure senza virgolette – il contenuto delle controdeduzioni della appellata, ha esplicitamente premesso di fare proprie le argomentazioni esposte dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate) ma soprattutto perché, come già rilevato, per la sentenza, che non è opera letteraria, non conta la paternità del testo nelle sue modalità espressive ma l’attribuibilità al giudice dei suoi contenuti, derivante dal fatto che quei contenuti sono stati “fatti propri” dal suddetto giudice nel momento in cui ha ritenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della decisione assunta, assumendosene la relativa responsabilità.
Peraltro, è certo possibile che la redazione della motivazione della sentenza attraverso la tecnica del collage esponga il giudice – in misura maggiore che non nell’ipotesi di utilizzo di altre tecniche redazionali – al rischio di trascurare domande, eccezioni e rilievi ovvero – eventualmente per un malaccorto uso del “copia – incolla” – di rendersi incomprensibile. Tuttavia in questo caso l’omessa pronuncia, il difetto o l’apparenza della motivazione andranno denunciati e valutati di per sè, con esclusivo riferimento al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti.
E’ inoltre da evidenziare che, non rilevando il percorso psicologico del giudice ma le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione, neppure può dedursi in maniera aprioristica (come invece sostenuto nel motivo in esame dal fallimento ricorrente) che, per il solo fatto di essersi limitato a riportare le argomentazioni di un atto di parte, il giudice abbia omesso ogni autonoma valutazione (ovvero abbia omesso di considerare le ragioni della controparte), se ciò non emerge in maniera oggettiva dalla motivazione, ben potendo il giudice avere autonomamente valutato le posizioni ed argomentazioni di entrambe le parti e deciso di conseguenza, utilizzando poi per motivare la propria decisione le ragioni esposte nell’atto di una delle parti (eventualmente anche senza nulla aggiungere ad esse) in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta (ad esempio perché, trattandosi di un atto “in risposta” ad altro atto di controparte – come nella specie, in cui sono state riportate in sentenza le controdeduzioni in appello -, in esso potrebbero essere già state prese in considerazione – in maniera ritenuta dal giudice corretta e condivisibile – le ragioni della controparte).
E’ ancora da precisare che è destituito di fondamento l’assunto (apparentemente condiviso dal ricorrente laddove lamenta la mancata esplicitazione in motivazione delle ragioni della totale adesione del giudice alle tesi della controparte) secondo il quale, quando aderisce alle ricostruzioni, impostazioni, argomentazioni poste da una parte a sostegno delle proprie pretese, il giudice deve poi necessariamente motivare le ragioni di tale adesione.
Il codice prevede infatti solo che il giudice assuma una decisione ed esponga poi le ragioni di tale decisione (coincidenti o meno che siano, in tutto o in parte, con quelle esposte da uno dei contendenti a sostegno delle proprie pretese), ma non prevede altresì che, in una sorta circolo vizioso, esponga anche i motivi per i quali abbia eventualmente condiviso le ragioni sostenute da una delle parti, posto che tali ragioni, se valide, sono idonee di per sé a sostenere la decisione assunta, senza che sia necessaria una ulteriore motivazione riguardante (non già le ragioni della decisione bensì) le ragioni per cui le suddette “ragioni della decisione” corrispondono a quelle esposte da una delle parti a sostegno delle proprie pretese.
Certo, è possibile che quanto affermato da una parte sia “contrastato” (in fatto e in diritto) dall’altra parte, ed in questo caso la sentenza nella quale il giudice si limitasse a riportare le ragioni esposte da una delle parti senza prendere in considerazione quelle contrapposte dall’altra sarebbe censurabile se ed in quanto oggettivamente incompleta, non certo per la mancata esplicitazione dei motivi di adesione alle tesi di una delle parti nè tanto meno per il solo fatto che la relativa motivazione risulta costituita dalla mera riproduzione del contenuto di un atto di parte.
L’unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo se il contenuto dell’atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione. Esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile.
4.- E’ ancora da sottolineare l’infondatezza dell’assunto (invero riscontrabile soprattutto con riguardo alla motivazione di sentenze penali) secondo il quale la motivazione della sentenza redatta riportando il contenuto di atti di parte sarebbe da ritenersi sintomatica di un difetto di imparzialità e/o terzietà del giudice.
L’imparzialità del giudice va infatti identificata nella sua personale indifferenza alle sorti ed all’esito del processo, risolvendosi nella mancanza di presupposti (soggettivi, oggettivi, psicologici) idonei a condizionare il contenuto della decisione.
La Corte costituzionale ha riempito di concretezza il concetto di imparzialità già a partire dalla sentenza n. 155 del 1996, nella quale ha affermato che essa “richiede che la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto terzo, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia del decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza”. Sulla base di questo storico arresto della Consulta è quindi possibile affermare che l’imparzialità del magistrato presuppone: 1) l’inesistenza di un suo interesse personale nella causa e la sua estraneità rispetto alle parti del processo; 2) l’inesistenza di precedenti decisioni assunte sulla medesima regiudicanda in altri gradi o fasi del medesimo processo.
Come è evidente, nessuna di tali situazioni è ravvisabile nell’ipotesi in cui, decisa la controversia, il giudice ritenga di motivare la decisione utilizzando nella redazione della sentenza gli atti di parte (evidentemente ritenuti idonei allo scopo), essendo palese che, con riguardo ad una determinata controversia, l’imparzialità va valutata in riferimento a posizioni, interessi o attività del giudice anteriori alla decisione, non ad essa successive.
Invero, nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo – e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all’altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti.
D’altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni. E quando ciò dovesse accadere, cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l’istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più “trasparente”, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell’atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una “originalità” espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico.
In ogni caso non potrebbe sicuramente ravvisarsi un sintomo di parzialità del giudice nel fatto che egli abbia motivato la decisione riportando in sentenza il contenuto di un atto di parte, giacché l’imparzialità è – alla stregua delle disposizioni del codice di rito e della Costituzione siccome interpretate dalla Corte costituzionale – ben altro che non una sorta di “pudore” formale postumo, e comunque non basterebbe certo un mutamento di registro stilistico a garantirla.
5.- E’, infine, necessario chiarire i limiti entro i quali possono ritenersi valide le argomentazioni finora svolte ed i principi che dalle stesse debbono trarsi, anche in relazione all’ordinanza interlocutoria che, nel sollecitare l’intervento di queste sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., ha prospettato possibili ricadute della decisione “pure al di fuori del processo tributario, nei processi civili e penali (nonché nei giudizi disciplinari su comportamenti similari)”.
Se è vero infatti che nessuna sentenza o atto processuale costituisce opera letteraria o comunque artistica, come tale soggetta alla disciplina del diritto d’autore, le considerazioni sopra esposte circa l’insussistenza nel codice di rito di norme, esplicite o implicite, che impongano al giudice l’originalità nei contenuti e nelle modalità espositive delle sentenze o gli vietino di riportare in esse il contenuto di atti di parte devono ritenersi allo stato riferibili esclusivamente alle sentenze e ai provvedimenti giurisdizionali civili e (in virtù del rinvio al codice di procedura civile contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in assenza di diverse disposizioni in materia nel suddetto decreto ovvero di incompatibilità con le previsioni di esso) ai provvedimenti giurisdizionali emessi dalle Commissioni tributarie, non, pertanto, ai provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice penale. E ciò non per avere questo giudice valutato che le suddette considerazioni non trovino riscontro nella legislazione processuale penale, ma semplicemente perché, nei limiti della devoluzione occasionata dal ricorso in esame e delle attribuzioni di queste sezioni unite civili, la presente indagine è stata condotta esclusivamente alla stregua del codice processuale civile e della giurisprudenza ad esso riferibile.
Da ultimo, va aggiunto che la sentenza, in quanto espressione dell’attività del giudice, può venire in rilievo quando questa attività deve essere apprezzata a fini disciplinari o professionali, e comprensibilmente la valutazione professionale e disciplinare si pone su di un piano diverso rispetto a quello della validità della sentenza quale atto processuale, benché quest’ultimo profilo possa ovviamente condizionare il primo. A tale proposito, deve evidenziarsi la sostanziale continuità tra la decisione assunta in questa sede ed i più recenti arresti di queste sezioni unite in materia disciplinare.
In particolare, deve escludersi che sussista discontinuità con la sentenza n. 10627 del 2014 nella quale queste sezioni unite hanno confermato la sanzione irrogata ad un giudice per le indagini preliminari che aveva motivato due provvedimenti disponenti misura cautelare (rispettivamente relativi a nove e diciotto indagati) riportando in essi il testo della richiesta del Pubblico Ministero e (in uno dei due) anche parti di motivazione di ordinanze cautelari emesse nell’ambito di differenti vicende giudiziarie. E ciò non per la diversità delle valutazioni richieste nel giudizio disciplinare né per il fatto che nella specie viene in considerazione un provvedimento del giudice penale, ma per il fatto che, come risultante dalla citata sentenza, nel caso di specie il giudice non si era neppure curato di “fare proprie”, in modo da renderle a sè riferibili, le considerazioni espresse nella richiesta del P.M. ricopiata nel proprio provvedimento (avendo riportato – senza virgolettature e senza adattamento – passi della suddetta richiesta contenenti espressioni come “presente richiesta cautelare”, “questo P.M.”, “codesto GIP”, “si richiede la cattura”) ed inoltre aveva ricopiato passi della motivazione di altri provvedimenti riguardanti casi diversi da quello trattato, facendo riferimento nella parte conclusiva dell’ordinanza a fatti non risultanti dalla contestazione.
Deve anzi sottolinearsi la coerenza, con quanto deciso nel citato precedente, di quanto in questa sede sostenuto, in particolare laddove si è evidenziato che la chiarezza, inequivocità ed esaustività della motivazione e, prima ancora, la chiara riferibilità di essa al giudice che la sottoscrive costituiscono il presupposto della validità di qualunque sentenza, quindi anche (e a maggior ragione, considerati i rischi ai quali espone una tecnica redazionale “a collage”) di quella redatta attraverso la ricopiatura di scritti altrui (atti processuali, compresi quelli di parte, o altri provvedimenti giudiziari).
E neppure può ravvisarsi sostanziale discontinuità con riguardo alla sentenza n. 10628 del 2014 di queste SU (relativa a disciplinare a carico di magistrato che in due sentenze civili aveva motivato la decisione riportando il contenuto della comparsa conclusionale di una delle parti), anche se potrebbe indurre a diversa valutazione il tenore della massima ufficiale (in cui viene riportato uno degli obiter della sentenza, la quale peraltro prevede la cassazione senza rinvio della pronuncia disciplinare di condanna), dovendo inoltre rilevarsi che in altro obiter della decisione in questione vengono espressi, sia pure in nuce, concetti sviluppati in questa sede (in particolare laddove, nella citata decisione, si afferma che “le esigenze di celerità e le sempre crescenti possibilità offerte dagli strumenti informatici, in una alla non necessità che il dictum giurisdizionale costituisca un prodotto in ogni parte originale, impongono di attenuare il rigore della ricorrente enunciazione secondo la quale invece la rilevanza disciplinare può escludersi solo quando il pedissequo recepimento di un atto difensivo concerna parti meramente descrittive”).
Dall’argomentare che precede deve trarsi il seguente principio di diritto: “Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E’ inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti”.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato e gli atti devono essere rimessi alla quinta sezione civile per la decisione degli altri motivi e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e rimette gli atti alla quinta sezione civile per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015
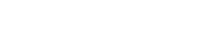
Leave a reply